Intervista a Simona Eleuteri, la ricercatrice che vuole sconfiggere le malattie neurodegenerative
Scritto da Stannah il 22-05-2019
Da settembre 2018 Stannah sostiene il programma Longevity di Fondazione Umberto Veronesi. Dopo alcuni mesi di attesa, che sono serviti a Fondazione Umberto Veronesi per chiudere il bando di selezione dei ricercatori e vedere assegnati i progetti, a gennaio 2019 Stannah ha potuto conoscere di persona il suo ricercatore. Si tratta di una ricercatrice, per l’esattezza, e si chiama Simona Eleuteri. Classe 1979, nata in Basilicata e cresciuta in Abruzzo, Simona è rientrata dal 2015 in Italia con il piano di rientro dei cervelli finanziato dall’Unione europea. Dall’inizio del 2019, anche grazie al contributo di Stannah, lavora assieme a un team di ricercatori dell’Istituto Clinico Humanitas (Milano) su un progetto di ricerca per trovare una cura per il Parkinson.
Ci parli del programma di ricerca che state sviluppando grazie a Fondazione Umberto Veronesi e a Stannah e ci dica: ci sono speranze per il miglioramento della vita dei malati di Parkinson?
“Il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più comune al mondo e colpisce l’1% della popolazione sopra i 65 anni di età e dal 3-5% della popolazione sopra gli 85 anni. I sintomi principali sono tremori e movimenti involontari ed eccessivi, oltre a disturbi del linguaggio, depressione e molto altro. Oggi le terapie attuali consentono di controllare solo gli effetti secondari del Parkinson, ma non la progressione della malattia e la degenerazione dei neuroni. Noi abbiamo individuato una proteina chiamata VPS35 che rappresenta un potenziale target terapeutico, perché favorisce lo smaltimento di aggregati tossici nel cervello dei malati. Stiamo testando, dunque, la capacità di questa molecola di agire come farmaco, bloccando lo sviluppo della patologia e la morte neuronale. In tempi rapidi prevediamo lo sviluppo di un potenziale farmaco da poter testare in fase di sperimentazione clinica sui pazienti”.
Quando è nata la sua passione per la medicina e per le scienze?
“E’ difficile stabilire quando sia nata la mia passione per la ricerca scientifica, perché credo che abbia radici profonde e sia stata alimentata in maniera trasversale già dalla mia infanzia e dall’essere cresciuta in una famiglia con stimoli letterari e scientifici. Da una parte mia madre, insegnante, mi raccontava novelle di Pirandello e mi parlava di filosofia, e dall’altra parte mio padre, che svolgeva mansioni hardware e software in giro per il mondo, mi ha trasmesso l’interesse per gli studi tecnologici e scientifici. Molto importante è stato anche il ruolo di mio fratello maggiore, che ora è un rianimatore e ha certamente contribuito ad aumentare il mio interesse verso la medicina e verso gli studi scientifici. Aggiungiamo una forte dose di curiosità innata, che negli anni si è unita all’empatia e alla voglia di dare una speranza alle persone che soffrono, ed eccomi qui”.
Ci racconti il suo percorso di studi. E’ partita dall’Italia per arrivare a lavorare negli Stati Uniti e poi di nuovo in Italia. Come mai?
“Pensi che finito il liceo ero convinta di volermi iscrivere ad Architettura. Ho fatto il test per entrare alla Sapienza a Roma e l’ho superato. La mattina successiva al test ho accompagnato la mia migliore amica all’Università di Bologna, e lì – invece – ho avuto un’intuizione chiara e definitiva. Altro che Architettura. Mi sono iscritta alla facoltà di Scienze Biologiche all’Alma Mater Studiorum di Bologna, specializzandomi in biologia Biomolecolare che mi guidava direttamente verso la carriera di ricercatore. Poi è stata la volta del dottorato di Ricerca in Biologia e Fisiologia Cellulare e infine dopo meno di un anno ho vinto una borsa di mobilità internazionale all’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Infine, la mia esperienza all’estero è continuata all’University California San Diego (UCSD) negli USA. Gli anni all’UCSD mi hanno permesso di acquisire il mio metodo scientifico, che parte dallo studio dei meccanismi molecolari delle malattie neurodegenerative fino allo sviluppo di un farmaco che possa bloccare la patologia nei pazienti”.
La scelta di rientrare in Italia con il programma del rientro dei cervelli da cosa è nata: nostalgia di casa? Oppure un senso di responsabilità verso il Paese?
“Ogni carriera ha una sua pianificazione e la mia ha sempre previsto il rientro in Italia per ragioni affettive e di dovere verso il mio Paese. Il mio desiderio più grande è stato sempre quello di formare un gruppo di ricerca che avesse come base l’Italia, ma che usufruisse dei contatti internazionali che avevo creato negli anni in Europa e negli USA. Il rientro a Milano per me ha rappresentato un compromesso ottimo, perché sento di riuscire a mantenere un livello alto di ricerca in Italia, e di esser guidata da professori di grande esperienza”.
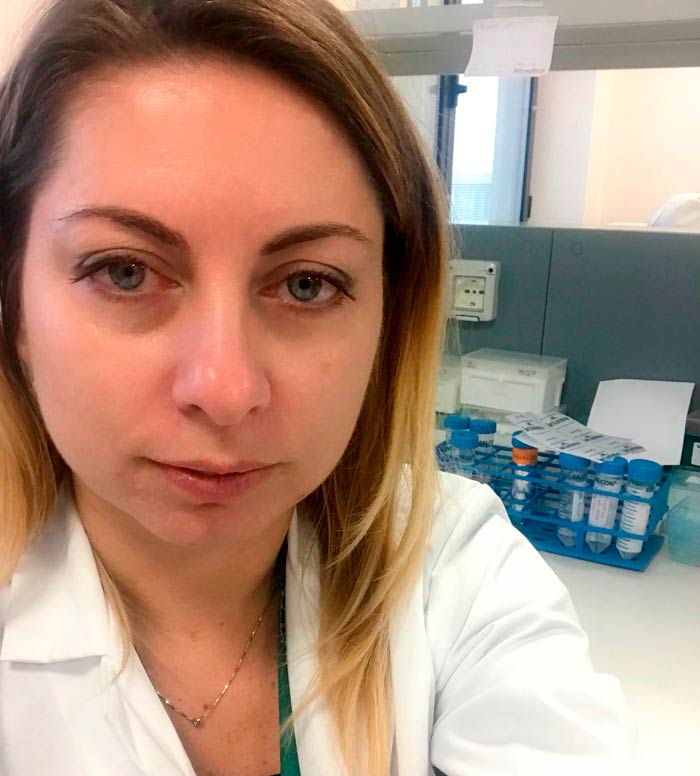
Com’è stato lavorare da ricercatore negli Usa, la patria della ricerca e dell’innovazione?
“Premettiamo che le condizioni essenziali per fare ricerca sono uguali in tutto il mondo. Oltre alla preparazione didattica e allo sviluppo di un metodo scientifico, al ricercatore è richiesto o di avere o di sviluppare alcune caratteristiche caratteriali e comportamentali: una passione che supera la logica, ottimismo critico e cronico, dedizione, pazienza infinita, spirito di sacrificio e capacità di seguire e credere ai propri sogni visionari.
In particolare negli USA fare ricerca significa conoscere lo scibile umano e non applicare alle proprie idee nessuna limitazione, se non quelle etiche. Al ricercatore americano si chiede di non imitare, ma di essere se stesso al massimo.
Quel che è straordinario nelle Università americane è il continuo confronto con mentori e superiori, che frequenti anche fuori dagli orari lavorativi. Il laboratorio diviene una casa e un punto di riferimento. Un senso di ottimismo ti pervade, perché si lavora fianco a fianco con ricercatori e laboratori che hanno cambiato il corso della scienza e della vita delle persone”.
Come è la vita di laboratorio? È severa, asettica e silenziosa come viene proposta dai media?
“Tutto il contrario. La vita del laboratorio ha molti colori e tante lingue e rappresenta la massima multietnicità, poiché integra persone da tutto il mondo. Il laboratorio diventa una casa, dove si festeggiano eventi privati, come compleanni e festività e successi lavorativi, come promozioni, pubblicazioni e vincite. I legami più forti della mia vita sono nati con i miei colleghi in giro per il mondo. Ho incontrato persone che venivano dall’Africa, dall’Asia, dallo Yemen e ho imparato le loro tradizioni, chi e cosa avevano lasciato ad aspettarli e cosa avevano perso per sempre. Asad è un medico pakistano, per esempio, che mi ha guidato con successo nel mio lavoro di dottorato di ricerca di drug discovery nell’Alzheimer in Svizzera. Lui scappava dal suo Paese perché gli avevano destinato una moglie e sentiva la voglia di scegliere la sua compagna di vita. Martial aveva 10 fratelli in Camerun e lavorando in Svizzera manteneva la sua famiglia. Ricardo è italo-venezuelano: era a San Diego con la moglie e le sue due figlie ed era presente quando uno dei più grandi giornali scientifici al mondo rifiutò una mia teoria, successivamente accreditata, e mi insegnò a produrre lavori di qualità, anche se non sempre riconosciuti. Mi disse che il suo lavoro più citato fu pubblicato sulla rivista scientifica più modesta possibile e dopo 10 anni scrissero un libro su questo piccolo articolo e vinse il posto come professore associato all’UCSD. Con Klodjan abbiamo lavorato insieme a Bologna, poi all’EPFL e all’UCSD, diventando fratelli e raggiungendoci quando possibile in ogni angolo di mondo. Ho incontrato molti studenti con i quali ho affrontato le notti in laboratorio ascoltando musica senza interruzione. La combinazione di mente e anime predisposte alla ricerca rende un ambiente, che in foto potrebbe sembrare asettico, pieno di colori, di odori e di lingue differenti”.
Stannah sostiene Longevity, il programma di Fondazione Umberto Veronesi dedicato alla salute e al miglioramento della qualità della vita degli over 60. Pensi che le aziende private sostengano a sufficienza la ricerca in Italia? Ci vorrebbe maggiore impegno? E lo Stato? Potrebbe fare di più?
“Ho avuto modo di conoscere Stannah da vicino in relazione al finanziamento del mio progetto e sono stata sorpresa piacevolmente dall’organizzazione e dalla gestione del personale. I dipendenti erano accomunati dalla missione di agevolare il cliente e aiutarlo nel processo d’installazione dei dispositivi. Credo che in Italia in generale sia Stato che aziende finanzino molto poco la ricerca scientifica e che i finanziamenti stiano progressivamente diminuendo. Ciò che non risulta chiaro è che la ricerca scientifica e tecnologica dovrebbero rappresentare i capisaldi per lo sviluppo di un Paese. Troppe volte il ricercatore è associato all'”appassionato” e troppe volte ho incontrato menti brillanti in Italia che sono state forzate dalle esigenze economiche ad abbandonare il loro lavoro. L’Italia forma con la laurea ricercatori, medici eccellenti che regala all’estero e non prevede una strutturazione solida per i professionisti. Ci sono pochi finanziamenti e buchi incredibili per chi si è già formato come professionista. In Italia un ricercatore sopra i 40 anni, se non ha raggiunto i livelli massimi è costretto a lasciare la ricerca e non solo per problemi economici, ma anche per mancanza di risorse (reagenti etc) con le quali effettuare gli esperimenti. È importante la formazione, ma si tratta di un’arma a doppio taglio quando non è prevista la stabilizzazione dei professionisti formati. Il gioco rischia di essere sbilanciato nella formazione continua e non nel supportare professionisti che hanno già dedicato la loro vita alla ricerca”.
Una volta il lavoro del ricercatore era quasi come quello del “missionario”. Pochi soldi, poche soddisfazioni, tanta fatica e impegno. Giusto per dare un messaggio ai giovani che vorrebbero intraprendere questo percorso: è ancora così?
“Io credo che per sviluppare un Paese che possa competere con l’Europa e i panorami internazionali ci sia l’esigenza di modificare la visione del lavoro del ricercatore. Per poter pensare e osare non è possibile avere problemi economici. Il ricercatore ha bisogno dei mezzi per portare avanti in tranquillità le dure prove sperimentali che come detto prima si protraggono per anni. Si tende ad accentrare troppo lavoro su una sola persona, la quale può perdere il focus e lucidità. È importante diversificare i ruoli, in modo da elevare i livelli dei progetti, ridurre le tempistiche per essere produttivi, efficienti e attendibili. La ricerca dovrebbe essere intesa come un’azienda, dove ci sono dipendenti che hanno punti di riferimento superiori e gestiscono la formazione di altre persone, creando una catena solida che promuove la professionalizzazione. Per giovani che vogliono intraprendere questo percorso ripeterei un messaggio essenziale: ricercatori non si nasce, ma si diventa. I migliori ricercatori potrebbero essere quelli che non volevano esserlo da piccoli, ma che crescendo hanno accettato la sfida di poter migliorare se stessi e il mondo nel quale vivono. Basta affinare lo sguardo, scendere gradualmente in profondità accompagnati dalle giuste guide.
Nel tempo libero cosa le piace fare? Quali sono le sue passioni?
“La mia più grande passione è il viaggio, perché mi permette di uscire dalla mia “comfort zone”, mettermi alla prova, per testare i miei limiti ed eliminare l’abitudine. Quando viaggio mi viene in mente sempre questa immagine della mia mente come una soffitta riempita da idee, alcune delle quali impolverate e senza colori da riordinare o eventualmente eliminare nei chilometri a piedi, in vecchi autobus o in lunghi tragitti in aereo. Lontano dalla routine si ha il coraggio di salire le scale della soffitta, abbassare le difese e camminare tra sogni, pensieri e desideri e abbandonare ciò che non ci rende felice. La fotografia è la lente attraverso la quale osservo l’esterno, non come protezione ma come zoom di quello che mi cattura di più. Ho visitato delle etnie minoritarie sulle Ande (Quechua) e nel nord del Vietnam (Hmong e Dzao) e il regalo più grande per me è di entrare nelle loro vite, chiaramente in punta di piedi, senza essere considerata una turista, ma sviluppando la capacità di interagire e di creare un legame con persone tanto diverse.
In un lungo viaggio in autobus in America centrale incontrai un signore di mezza età, che mi chiese se fossi una fotografa catturato dal mio modo intenso di osservare e soffermarmi sulle cose. In quel momento ho capito cosa legava la fotografia alla ricerca: l’intensità con la quale si osserva il mondo! Fare ricerca è stato un grande vantaggio anche per la mia voglia di conoscere il mondo perché oltre i tanti viaggi intrapresi per conferenze e lavoro, mi ha permesso di passare a un livello superiore inserendomi in diverse culture, imparando lingue diverse e vivendo stabilmente in Europa e negli USA. Inoltre, negli anni di Università e nel Dottorato la mia alimentazione quotidiana è stata la lettura, il cinema, seguire le lezioni di filosofia che mi hanno sicuramente avvicinato al lato umano delle persone e successivamente dei pazienti”.